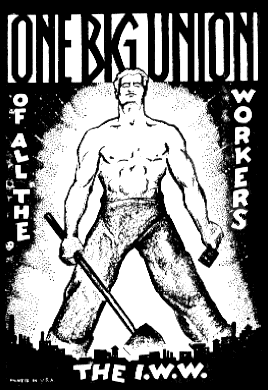da Contrattazione - Rivista bimestrale della CISL, luglio-ottobre 1978, pp. 5-25

È corretto rilevare che storicamente nelle rivendicazioni sull'orario di lavoro, pur essendo presenti ambedue le componenti di fondo del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'allargamento delle opportunità occupazionali è stata la prima quella prevalente.
Questa giusta osservazione non va, però, intesa nel senso che la tradizione rivendicativa delle organizzazioni sindacali non contenga consistenti e significative esperienze in cui sull'orario si è cercato di intervenire proprio avendo principalmente di mira i problemi occupazionali.
Anzi, vanno colte in tutto il loro significato le circostanze in base alle quali questo approccio alla riduzione dell'orario (guardare alle condizioni di lavoro degli occupati e insieme a quelle dei disoccupati) è emerso in passato anche a livello legislativo.
Nel nostro paese, il dibattito sulla riduzione dell'orario e sui conseguenti effetti economici ed occupazionali, risale molto in là nel tempo.
Già nel 1891 il Dalla Volta [1] dedica a questo problema una monografia. A sua volta, nell'anno successivo Emilio Cossa [2] guarda alla riduzione dell'orario ed alla generalizzazione delle 8 ore come una via concreta per far fronte alla "questione sociale". Egli afferma: "L'agitazione dei lavoratori ha origine da un contrasto sempre crescente a cui danno luogo oggidì i fenomeni dell'organismo industriale per ciò che riguarda la domanda di lavoro. La classe operaia è ora più che mai divisa in due grandi schiere: quella degli occupati e quella dei disoccupati, ambedue malcontente ed inquiete. Da una parte vi hanno migliaia di individui di ambo i sessi e d'ogni età, obbligati a molte ore di lavoro e con salari generalmente fermi; dall'altra, vi ha un numero pure assai grande di persone in età produttiva la cui opera non è cercata. Di fronte a tale fatto, si chiede dalle classi operaie che migliori la sorte degli uni e si renda ad un tempo necessaria l'opera degli altri.
I progressi a cui è giunta l'industria, l'immensa quantità di capitale e di lavoro disponibile in sul mercato sono, nella mente degli operai, circostanze le quali possono permettere che si lavori meno".
Scopo del presente contributo - molto sommario ed incompleto - è mettere in luce alcuni momenti, soprattutto di natura legislativa, della storia della riduzione dello orario, ricca di stimoli anche per le scelte che oggi il sindacato deve compiere.
Fra l'altro, si intende fornire qualche elemento per evidenziare l'uso strumentale che di alcuni riferimenti storici è stato compiuto nelle recenti polemiche, anche interne al sindacato (come è, ad esempio, per l'affermazione che il movimento operaio non avrebbe mai rivendicato la riduzione di orario in momenti di crisi).
2 - Uno dei primi interventi legislativi dello stato nella disciplina dei rapporti di lavoro, si è registrato proprio in materia di durata della prestazione lavorativa. Nel nostro paese quest'intervento è stato condizionato dal tipo di sviluppo industriale realizzatosi sul finire del secolo scorso e, più in generale, dal ritardo del processo di sviluppo sociale italiano rispetto a quello di altri paesi. Anche da noi, comunque, la evoluzione storica della disciplina legale del tempo di lavoro ha attraversato tre fasi successive: limitazione del lavoro dei fanciulli; limitazione del lavoro delle donne; limitazione del lavoro dei lavoratori adulti. Lo sviluppo industriale italiano trova il suo più significativo elemento di spiegazione nello sfruttamento di una forza-lavoro praticamente libera e illimitata, sfruttamento di cui il prolungamento smisurato e indeterminato della giornata lavorativa è aspetto essenziale. Mentre i padroni "non garantiscono in alcun modo agli operai lavoro continuo" [3], si riservano, però, "il diritto di ridurre od aumentare il numero delle ore a seconda della stagione e a norma delle esigenze di fabbrica". E così l'inchiesta sulle fabbriche [4] del 1877 rivela che "si può ritenere assai prossimo al vero una media di 11-12 ore al giorno di lavoro effettivo".
Se l'obiettivo dei datori di lavoro è quello di mantenere mano libera nella definizione della durata dell'attività lavorativa, la dottrina giuridica offre sostanziale sostegno a tale posizione padronale. È, infatti, di notevole rilievo che, nell'opera a ragione considerata quale punto di partenza per l'avvio di un organico diritto del lavoro, vale a dire "Il contratto di lavoro" del Barassi, si ponga una distinzione tra una visione "di puro diritto" per la quale non può dubitarsi che la prestazione del lavoro possa ben prolungarsi nella giornata a discrezione della libera volontà delle parti ed in particolare secondo le esigenze dell'imprenditore, e "considerazioni di ordine sociale"; e che questo autore arrivi successivamente alla seguente conclusione: "un limite generale massimo (alla prestazione lavorativa) non è legalmente determinabile; si pensi alla varietà grande di prestazioni di lavoro, alla conseguente impossibilità di dettare una misura uniforme per tutte senza incappare in limitazioni dannose, in qualche caso, all'industria..." [5].
Ciò premesso, non può far meraviglia se ancora nel 1901 il Cabrini [6] afferma che in Italia non esiste una vera legislazione sociale e che, nel quadro generale assai arretrato, le uniche disposizioni in materia di orario siano quelle contenute nella legge 11 febbraio 1886 e nel relativo regolamento, volti a limitare la giornata lavorativa a 8 ore per i fanciulli dai 9 ai 12 anni e la durata notturna a 6 ore per i fanciulli dai 12 ai 15 anni [7].
È solo con una successiva legge, quella n. 242 del 19 giugno del 1902, che viene regolato il lavoro femminile. Questo provvedimento fissa per le donne di qualsiasi età a 12 ore giornaliere l'orario massimo di lavoro. Il lavoro notturno, invece, è vietato solo alle donne minorenni [8]; inoltre, viene portato a 12 anni il limite di età per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e vietati ai minori di 15 anni i lavori che una commissione governativa ritenga pericolosi e insalubri.
La legge del 1902, viene, poi, parzialmente modificata con la legge 7 luglio 1907, n. 416, successivamente confluita nel T.U. sul lavoro delle donne e dei fanciulli (legge 10 novembre 1907, n. 818), T.U. che introduce - seppur con numerose eccezioni - il divieto del lavoro notturno per le donne di qualsiasi età.
Scarso era, dunque, il grado di tutela assicurato dalla legge. Se qualche limitazione è opposta - in questo periodo - al potere organizzativo dell'imprenditore in tema di orario, questo viene direttamente dall'azione collettiva dei lavoratori.
"La lotta contro il lavoro dall'alba al tramonto - rileva Stefano Merli nella sua Storia del proletariato di fabbrica - e per la conquista di un orario più umano è stata impostata e condotta primieramente in Italia dal proletariato femminile e infantile delle filande, che il regime di fabbrica costringeva anche a 16 ore di lavoro al giorno..." [9].
Lo stesso autore ricorda l'importanza delle azioni di sciopero scoppiate nel giugno del '93 nelle filande di Bergamo, in cui erano praticati gli orari più pesanti, che danno luogo al primo grande sciopero generale interprovinciale di categoria (grazie ad esso l'orario viene ridotto da 15-16 ore a 10 ore l'inverno e 11 l'estate; e il salario è aumentato di 10 centesimi giornalieri) ed indicano la strada della lotta come quella più proficua per la conquista di un orario di lavoro migliore. Anche se nei documenti della CGIL dal congresso delle Camere del lavoro del 1893 a quelli del periodo prebellico la questione dell'orario non è posta [10], essa emerge - oltre che in quelle già ricordate - in significative esperienze di contrattazione a livello locale.
Fra l'altro, la contrattazione non si limita a considerare solo il problema della riduzione quantitativa dell'orario. Essa viene a disciplinare anche le modalità di utilizzo dell'arco di ore stabilite per la prestazione lavorativa. "Nei mesi di maggior calore estivo ed in altri casi eccezionali - si legge nel concordato fra le leghe dei muratori e dei capimastri di Imola del 3 marzo 1909 - sarà in facoltà delle squadre di operai di procedere, d'accordo coi capimastri o direttori dei lavori, ad una più comoda distribuzione delle ore di lavoro".
Altre linee, lungo cui la contrattazione si muove, riguardano l'esigenza di porre un freno agli effetti più diretti del macchinismo e del progresso tecnico sulla condizione operaia.
Non mancano, infatti, esempi di lotta con forti contenuti di solidarietà, in cui - di fronte ai processi di razionalizzazione - si cerca di autolimitare il lavoro per salvare l'occupazione per tutte le maestranze della fabbrica [11]. Un esempio significativo di azione sindacale sui rapporti fra innovazioni tecnologiche, occupazione, condizioni di lavoro e orario è quella che si svolge, a cavallo del secolo, nella categoria dei tipografi in relazione all'introduzione della composizione meccanica (linotype, monotype). I tipografi erano una delle categoria meglio retribuite e la Federazione del libro una delle prime organizzazioni sindacali costituite su dimensione nazionale. Ma le macchine per comporre, sostituendo un gran numero di compositori a mano, venivano a costituire un grosso pericolo per l'occupazione. Notava, infatti, un giornale sindacale dell'epoca [12]: "Dieci anni fa la classe tipografica poteva in Italia imporre condizioni a piacer suo, e, se organizzata saldamente, aveva ogni probabilità di vederlo accettate, perché un tipografo scioperante non poteva essere sostituito che da un altro che avesse i suoi anni di tirocinio, e non da un operaio qualsiasi. Oggi... anche il tipografo deve fare i conti con la macchina che elimina due operai su tre.
È una brutta concorrente, ma alla quale gli operai avrebbero torto di fare il viso dell'armi perché la macchina, che oggi costituisce il più potente fattore ad aumentare i pesi della classe lavoratrice, sotto altri rapporti sociali può diventare il mezzo più potente per ridurre ad una misura affatto insignificante la fatica del lavoro... Ogni tentativo di impedire lo sviluppo della macchina non farebbe che scemare le condizioni favorevoli per la emancipazione del lavoro... Infatti la macchina per comporre è il vero mezzo per arrivare alla conquista delle otto ore, anzi essa, qui in Roma, a differenza di tutti gli altri paesi del mondo, ha già realizzato la giornata di sette ore, con 9 lire di salario. Ciò però non significa che non si debba cercare di attenuare i danni che l'introduzione della macchina provoca immediatamente - grande disoccupazione, profonda depressione della classe lavoratrice - non ostacolandola ma cercando che l'adozione ne sia graduale. Invece la domanda delle 8 ore con l'aumento del 24% del salari ristabilisce l'equilibrio che mancava fra il costo del lavoro alla cassa e il lavoro alla macchina...". La strada appariva chiara fin da allora: la risposta alle modifiche che il padrone introduce nell'organizzazione del lavoro e che hanno la conseguenza di minare le basi del potere contrattuale dei lavoratori, non può essere di chiusura corporativa e difensiva, ma deve diventare di attacco sullo stesso terreno: se in discussione vengono messi i livelli occupazionali, una drastica riduzione dell'orario di lavoro servirà a garantirli. Infatti sia a Milano che a Roma vi furono In quegli anni scioperi numerosi e di lunga durata che permisero ai tipografi di ottenere fra i primi le otto ore di lavoro [13]. Questo tipo di problematica viene affrontata anche in altre categorie. Il concordato, stipulato nel 1905 fra la Federazione Metallurgica italiana e la Società alti forni, fonderie e acciaierie di Terni [14], muove dalle seguenti richieste (contenute nel memoriale inviato dalla commissione degli operai alla direzione aziendale): riduzione dell'orario da 12 a 8 ore, fermo restando il salario vigente; conseguente istituzione di 3 turni giornalieri di lavoro invece dei due già usati. Mentre le motivazioni poste a base della richiesta sono le seguenti: la produzione di 12 ore lavorative è aumentata in un anno per effetto di perfezionamenti tecnici da 20-32 a 44-60 Q, rendendo necessario per il caricamento dei forni un maggior lavoro; i salari fondati sulla produzione di 13 Q avrebbero dovuto essere aumentati; rinunciando i lavoratori a questi aumenti, l'istituzione di una terza squadra non aggiungerebbe molto alla spesa di manodopera necessaria. L'intervento più rilevante, realizzato dall'azione collettiva per contenere la facoltà padronale di determinare unilateralmente la durata del lavoro, è, comunque, rappresentato dalla contrattazione del lavoro straordinario, con trattazione che a volte coglie molto bene il collegamento fra gestione dei tempi di lavoro e andamento dell'occupazione.
"I proprietari non potranno pretendere dall'operaio, dopo la giornata normale di lavoro..., più di 3 ore straordinarie, e queste non potranno mai, salvo casi eccezionali, oltrepassare le 8 ore in una settimana", afferma la tariffa di lavoro concordata tra gli industriali tipografi di Viterbo e la Federazione dei lavoratori del libro [15], con l'ulteriore precisazione che "gli operai si rifiuteranno di lavorare nelle ore straordinarie qualora sianvi sulla piazza operai disoccupati".
Oppure, sempre nella stessa categoria, nelle tariffe e norme di lavoro del luglio 1920 per gli addetti ai giornali quotidiani di Roma si afferma che "solo per esigenze veramente eccezionali di servizio sarà permesso fare ore straordinarie di lavoro. Qualora poi in una tipografia con una certa costanza risultasse che il numero complessivo delle ore settimanali di straordinario raggiunga quello del lavoro ordinario di uno o più operai si dovrà, quante volte il numero delle macchine esistenti lo comporti, aumentare progressivamente il personale".
Nel settore agricolo, si può ricordare - come esempio di questa linea rivendicativa - il concordato di lavoro per l'anno agrario 1919-1920 della provincia di Rovigo [16], che limita l'effettuazione dello straordinario a "esigenze straordinarie dell'agricoltura o ragioni di intemperie" e alla condizione "che non ci sia disoccupazione".
Analogo criterio segue il concordato laniero nazionale del 17 Luglio 1920 [17]: "Le ore straordinarie saranno ammesse soltanto quando nel reparto per il quale sono chieste non vi sia disoccupazione".
Nonostante queste esperienze, resta, comunque, vero quanto affermato da Veneto [18] circa il controllo dello straordinario: "Non si disponeva (in genere) di alcun limite al criterio di valutazione predeterminato dalle eventuali esigenze dell'imprenditore. Può ben ritenersi che unico effettivo limite intrinseco fosse il tetto massimo di ore richiedibili, che pur rimaneva estremamente elevato, oltre, naturalmente, quello rappresentato dal costo, via via sempre crescente, delle singole unità di lavoro straordinario". Nel novembre del 1918 la FIOM inizia un movimento nazionale di tutti i metallurgici per le 8 ore e per la "inibizione contrattuale di pretendere (...) ore straordinarie". Le lotte che sostengono questa rivendicazione sono molto forti. Il 3 febbraio 1919 viene concluso a Genova un accordo di massima, perfezionato il 20 dello stesso mese [19].
L'accordo realizza le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali di orario normale. "Dopo trentanni - scrive Rigola nella sua storia - l'utopia delle 8 ore diventa realtà". Il citato concordato prevede per i meccanici e i siderurgici la possibilità di dieci ore di lavoro straordinario alla settimana, mentre per gli operai metalmeccanici, navali e affini ammette che al plafond delle 10 ore "si potrà derogare in casi urgenti e improrogabili".
Il freno più rilevante al ricorso allo straordinario è rappresentato - a conferma di quanto si diceva prima - dal costo definito come progressivamente crescente delle ore straordinarie.
L'accordo stabilisce, infatti, una maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria normale per le prime due ore di straordinario, del 60% per le successive 3, del 100% per le altre [20].
La conquista delle 8 ore, realizzata con il contratto dei metalmeccanici, da considerare comunque in base all'effettivo grado di attuazione e da porre in relazione ai processi di riconversione-ristrutturazione dell'apparato produttivo successivi alla guerra [21], incontra difficoltà ad essere estesa a tutto il proletariato italiano.
La crisi economico-sociale e, soprattutto, politica degli anni 1920-'22 rende, infatti, problematica la effettiva applicazione degli accordi che in quel periodo riprendono il principio del concordato dei meccanici.
"In molti concordati, infatti, il limite massimo di straordinario ed i vincoli per la sua esigibilità si mantenevano estremamente larghi, sì da permettere agli imprenditori un notevole svuotamento delle 'otto ore', nel loro significato di limitazione alla discrezionalità imprenditoriale di disporre nella giornata della forza lavoro. Né il costo delle ore di straordinario, come condizionamento ed indiretta limitazione agli abusi degli imprenditori e all'uso di tale strumento per non ampliare gli organici, sarebbe più cresciuto; smentendo così le aspettative (e le speranze) dei sindacalisti dell'epoca, che avevano pensato alla autoregolamentazione attraverso la contrattazione dell'orario di lavoro, sarebbe stato il legislatore a fissare il limite massimo dell'orario di lavoro in 48 ore settimanali e 12 di straordinario con il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692" [22].
3 - Una fase nuova in materia di regolamentazione della durata della giornata lavorativa, caratterizzata da una rilevante presenza legislativa, si ha nel periodo corporativo.
Nei primi decenni di questo secolo, il problema della durata del lavoro è considerata a livello internazionale - come una delle più acute questioni sociali. È, ad esempio, molto significativo che tale problema venga affrontato con forte rilievo nel preambolo della parte XIII del Trattato di Versailles dedicato, come è nolo, alla istituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel documento viene, infatti, posto l'obbiettivo dell'adozione della giornata di lavoro di 8 ore, o della settimana di 48 ore, come fine da raggiungere dovunque non sia stato ancora attuato [23]. Lo stesso Trattato stabilisce, poi, che la prima sessione della Conferenza internazionale del lavoro debba, fra l'altro, essere dedicata alla applicazione del principio della giornata di 8 ore o della settimana di 48.
La Convenzione, approvata dalla suddetta Conferenza svoltasi a Washington fra l'ottobre e il novembre 1919, è così intesa alla limitazione ad 8 ore per giorno e a 48 per settimana delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali. È in questo quadro internazionale, in cui molti legislatori in Europa e fuori intervengono nella materia, che si colloca, a 4 anni dalla Convenzione di Washington, il R.D.L. 15 Marzo 1923 n. 692. L'art. 1 del Decreto stabilisce, infatti, che "la durata massima normale della giornata di lavoro... non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali". Le caratteristiche generali del provvedimento adottato in Italia, la sua differenziazione, su aspetti anche non secondari, riguardo alla Convenzione di Washington, vanno comunque considerate in relazione a quella che è la specifica situazione italiana. Difatti, è indubbio che la legge sull'orario veniva a garantire una tutela minima a categorie di lavoratori non protette dalla contrattazione collettiva. Ma la preoccupazione prevalente, da cui essa scaturiva, era quella di correggere situazioni contrattuali - conquistate in periodo prefascista - in cui la riduzione dell'orario era ritenuta eccessiva dal regime. "La legge delle 8 ore del governo fascista ha reso più agile l'applicazione del principio, ha cancellato l'eccessivo formalismo burocratico, le complicazioni per quanto riguarda le deroghe e le eccezioni necessarie. Insomma, il governo ha applicato il principio delle 8 ore evitando la formula rigida. L'orario rigido non avrebbe avuto altro effetto che ridurre la produzione aggravando la situazione delle imprese..." [24].
E, infatti, la legge prevede un tetto per lo straordinario molto alto: l'art. 5 autorizza "quando vi sia accordo fra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro... di un periodo straordinario che non superi le 2 ore al giorno e le 12 settimanali, o una durata media equivalente entro un periodo determinato", prevedendo un plafond superiore a quello contenuto in molti contratti. Lo stesso art. 5 fissa, inoltre, nella paga normale maggiorata del 10% il compenso per lo straordinario: e tale maggiorazione è inferiore a quella stabilita dalla convenzione di Washington (che ammontava al 25%), oltre che a quelle previste dai contratti collettivi [25].
D'altra parte, è la stessa esigibilità dello straordinario da parte del datore di lavoro che viene resa più facile: si pensi, oltre ad altre deroghe all'applicazione del principio generale delle 8 ore [26], all'art. 9 del decreto n. 692 del marzo 1923 che allarga ulteriormente i confini dell'autonomia delle parti noi superare i limiti dello 48 ore settimanali e delle 12 ore di straordinario: eppure la contrattazione collettiva del periodo 1919-'20 ammetteva (in genere) nel settore industriale lo straordinario solo sulla base dei principi della "accertata saltuarietà", della "assoluta eccezionalità" e, a volte, del "necessario consenso del prestatore". La stessa linea di politica legislativa, di allargamento degli orari di lavoro, è, peraltro, rintracciabile anche rispetto ad altri settori.
"Nel 1919 - osserva Umberto Borsi nei suoi "Elementi di legislazione sociale" - la soluzione della questione delle 8 ore avvenne in via provvisoria, senza cautele atte ad evitare applicazioni esagerate, per il personale ferroviario, tramviario e della navigazione interna con i decreti luogotenenziali 15 maggio 1919 n. 775 e 8 giugno 1919, n. 1912...". Gustavo Del Vecchio, rincarando la dose, parla di conseguenze "assurde" derivanti dall'applicazione delle 8 ore alle funzioni ed ai servizi pubblici: "Le cosiddette 8 ore nei servizi statali, comunali ed anche nelle ferrovie e nelle compagnie di navigazione sovente si sono concretate in una esasperazione del solito parassitismo politico...". E, infatti, anche nei settori dei trasporti il regime correggerà il tiro con i regi decreti 22 luglio 1923, n. 1631 e 19 ottobre 1923, n. 2328, distinguendo fra lavoro effettivo e non effettivo e fissando orari medi.
4 - La crisi economica internazionale del 29, che coinvolge anche l'Italia e che trova nei primi anni '30 il suo acme, ripropone con forza la questione della riduzione dell'orario di lavoro.
Un'interessante occasione per cogliere il senso del dibattito presente nei vari paesi su questo tema è dato dall'attività del Bureau International du Travail e dagli atti delle Conferenze internazionali del lavoro del periodo. Difatti, nella situazione determinata dalla grande crisi, l'attività del BIT, che dopo un decennio riprendeva a studiare la questiono della riduzione dell'orario, fu impegnata e laboriosa.
"Nel secondo punto della sua risoluzione - dichiarava nel 1930 il direttore aggiunto del Consiglio di amministrazione del BIT - il consiglio di amministrazione ha insistito sull'eccesso di materiale utensile, sproporzionato alle possibilità di assorbimento dei mercati. Si tratta, dunque, di precisare in quale misura, anche nel caso di una produzione esattamente collimante con i bisogni, lo sviluppo del macchinismo e la trasformazione dei metodi, comprese tutte le procedure di razionalizzazione non meccaniche, possano privare del posto di lavoro un gran numero di lavoratori". La convinzione che nella "razionalizzazione" dei processi produttivi dovesse ricercarsi una delle cause più rilevanti della disoccupazione era diffusissima [27]. Riprove di ciò si ritrovano negli anni '30, anche in inchieste ufficiali, quali quelle promosse dalla Royal Commission on Unemployment Insurance e dall'Istituto federale germanico del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione, e in diverse altre pubblicazioni.
Tutti elementi, questi, che confermano la fondatezza della posizione assunta dai sindacati socialdemocratici europei dell'epoca e centrata sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario come misura per eliminare la disoccupazione.
Nel gennaio 1931, in seno alla Commissione per la disoccupazione del Consiglio di amministrazione, riunitasi per esaminare i mezzi più adatti per attenuare la disoccupazione, i rappresentanti operai sostennero che fra questi mezzi doveva figurare "una giudiziosa diminuzione della giornata lavorativa o della settimana lavorativa tenendo conto dell'aumento di rendimento ottenuto dal perfezionamento dei sistemi di produzione" [28].
La questione fu poi discussa, nell'ottobre dello stesso anno, dal Consiglio di amministrazione, che convocò di nuovo la Commissione per l'occupazione. Questa, riunitasi nel dicembre, adottò una risoluzione con la quale, tra l'altro, si consigliava la soppressione del lavoro straordinario, la riduzione del lavoro individuale sulla base di 40 ore settimanali per evitare licenziamenti e riassorbire disoccupati.
Successivamente, nella XVI sessione della Conferenza internazionale del lavoro dell'aprile 1932, il gruppo operaio fece mettere ai voti una risoluzione (approvata) che esprimeva la convinzione che la disoccupazione, generata dalla crisi, era causa di un aggravamento della crisi stessa, e che lo squilibrio fra produzione e consumi non doveva essere accresciuto da una condannabile politica di riduzione dei salari, che l'esperienza indicava come contraria ai reali bisogni dell'economia.
Un'ulteriore fase di dibattito si apre nel luglio del 1932, quando il rappresentante del governo italiano chiede la convocazione di una sessione speciale. Nella conferenza preparatoria del gennaio 1933, a cui partecipano 35 delegazioni di stati membri, i rappresentanti operai sostengono che lo squilibrio fra produzione e consumo sarebbe stato attenuato con una riduzione di orario, mentre il gruppo padronale affermava esservi una documentazione insufficiente e caso mai sfavorevole ad un simile provvedimento, oltre ad impossibilità di ordine pratico e tecnico-economico. La parte imprenditoriale, fra le altre osservazioni critiche, faceva rilevare che la riforma sarebbe stata poco operante perché inapplicabile negli stabilimenti con meno di 10 operai o che facevano uso di specialisti, rientrando in tale classificazione almeno il 50% dei lavoratori della industria. A queste osservazioni si replicava da parte dei rappresentanti dei lavoratori che tale percentuale decresceva nei paesi più industrializzati e che con la razionalizzazione della produzione diminuiva il bisogno di specialisti. Nella conferenza internazionale del giugno '34 viene proposta, per iniziativa della delegazione italiana, l'adozione della settimana di 40 ore, anziché di 48. La proposta, però, non incontra molti favori, per cui ci si limita a reinserirla all'ordine del giorno della successiva sessione della conferenza. Questa, che si svolge a Ginevra dal 4 al 25 giugno del '35, affronta la questione della durata del lavoro come tema centrale dei suoi lavori.
"Dopo due anni di discussione e di ricerche, eccoci di nuovo riuniti - afferma Capoferri, consigliere tecnico della delegazione italiana [29] - per trovare la soluzione ad uno dei problemi più gravi della nostra epoca, soluzione che milioni di uomini aspettano per uscire dalla disperazione in cui si trovano. La disoccupazione, come confermano i fatti, non ha solo aspetti materiali, ma anche morali...
La riduzione della durata del lavoro, specialmente nell'industria, è una misura che si impone senza indugi...
La tesi, secondo cui la causa principale della crisi che ha determinato la disoccupazione risiede nel rapido sviluppo del progresso tecnico, è universalmente accettata. Sarebbe un errore imperdonabile sostenere che il progresso tecnico non ha aumentato la capacità produttiva, e nessuno può contestare che, in numerose industrie, un solo operaio è in grado di produrre ciò che producevano 4 operai 20 anni fa".
A sua volta, il delegato dei Lavoratori francesi, Jouhaux, segretario generale della CGT, nel sostenere anche lui la necessità della riduzione dell'orario, pone, rivolgendosi ai rappresentanti padronali, le seguenti questioni: "Ma in fondo, questa ripulsa della riduzione delle ore di lavoro, questa affermazione che la riduzione delle ore di lavoro sarà una catastrofe, sono veramente legittimate dai fatti...? Se si accettasse il ragionamento padronale..., si ignorerebbero le caratteristiche dell'evoluzione industriale e dell'andamento dell'economia, ...Partiti all'inizio del XVIII secolo dalla giornata di 16 ore lavorative per arrivare, all'inizio del XIX secolo, alla settimana di 48 ore, arriviamo alla fine di questo secolo, alla giornata di 10 ore in Francia, 9 e mezza in Germania, e di 9 ore in Inghilterra... E forse che le industrie sono state bloccate nel loro sviluppo da questa riduzione delle ore di lavoro, e da questo continuo aumento dei salari? Se voi provaste questi fatti, allora potreste avere ragione... All'indomani della guerra..., gli uomini di stato hanno capito che il momento era venuto e in conformità della parte tredicesima del Trattato di Versailles, non hanno esitato a riavviare l'industria, e l'economia sulla base della giornata di 8 ore. In quel momento abbiamo ascoltato veementi proteste. Ma una volta di più le profezie non si sono avverate. Si è detto: è la fine della industria, è la rovina dell'economia industriale. Tutto crollerà. Non esisterà più nulla. In realtà, il sistema industriale per tre anni - nel 1920, 1921 e 1922 - ha avuto una produttività minore di quella del 1913. Ma già nel 1923 ha raggiunto i livelli di produzione del 1913 e nel 1923 si ha un indice della produttività di 108, nel 1924 di 112, nel 1925 di 121, nel 1926 di 123, nei 1927 di 131, nel 1928 di 137 e nel 1929 di 147. Ciò non è la prova che la giornata di 8 ore non è stata un attentato alla ristrutturazione dell'industria e allo sviluppo dell'economia?".
Significativo è anche il discorso di Delattre [30], Ministro del lavoro belga: "Il governo belga ha la volontà di riportare i disoccupati al lavoro: gli uomini che lo compongono hanno capito che nessuno stato può sopravvivere se una parte rilevante della sua popolazione non trova occupazione e deve vivere: di sussidi pubblici, sempre insufficienti. Il suo programma è ambizioso: esso punta al rinnovamento economico del paese. A questo scopo, sono già state preso importanti misure... La disoccupazione è così diminuita e un programma di lavori straordinari di circa due miliardi è stato elaboralo, o ne accentuerà la ripresa... Onesti lavori devono rappresentare l'avvio e, attraverso la crescita del monte salari, provocare una ripresa delle attività normali dell'industria, del commercio, della attività scientifica. Sono tutte queste attività che devono ritornare a pieno regime perché la situazione si normalizzi. Il vero, grande problema è questo ed esso si complica a causa del prodigioso sviluppo della tecnica che è diventata capace di soddisfare tutti i bisogni attuali con un numero considerevolmente ridotto di braccia. La verità essenziale, profonda e tragica al tempo stesso, è che, nonostante tutte le misure adottabili, non c'è possibilità di occupazione per tutti coloro che desiderano ed hanno bisogno di lavorare. Di conseguenza, come diceva M. Jacquier, vecchio ministro del lavoro di Francia, davanti al Senato del suo paese: ‹Poiché la quantità del lavoro è insufficiente, bisogna ripartirlo in modo più equo› ".
Numerosi sono gli altri interventi a favore della riduzione a 40 ore, fra cui anche quello del delegato del governo degli Stati Uniti. L'opposizione dei delegati di parte padronale è, però, molto forte. Si arriva così all'adozione di un progetto di convenzione concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, così riassumibile: considerate le estese proporzioni assunte dalla disoccupazione nel mondo per cui milioni di lavoratori risultano "in braccio alla miseria e alle privazioni", nell'intento di far partecipare le categorie lavoratrici ai benefici del progresso tecnologico, il cui rapido sviluppo caratterizza la industria moderna, e pertanto nella necessità di "tentare uno sforzo diretto a ridurre il più possibile la durata del lavoro in tutte le categorie di impiego", si afferma l'opportunità dell'applicazione del principio della settimana di 40 ore. Ciò per non determinare una riduzione del livello di vita dei lavoratori e al fine di adottare o di incoraggiare tutte le misure che potrebbero essere giudicate appropriate, per il conseguimento di tale obiettivo. Anche in Italia si registra, a questo riguardo, una situazione dinamica. A riprova di ciò, è interessante ricordare la polemica, ospitata sulle pagine di "La riforma sociale" [31], fra il senatore Giovanni Agnelli e Luigi Einaudi. La discussione è originata da una intervista del senatore Agnelli all'United Press, intervista in cui aveva sostenuto l'opportunità della riduzione dell'orario di lavoro. "Partiamo dalla premessa che ... nella parte industrializzata di questo nostro mondo, vi siano 100 milioni di operai occupati. Sia il loro salario medio di un dollaro al giorno ... Sulla base di un dollaro, ogni giorno nasce una domanda di 100 milioni di dollari di beni e servizi, ed ogni giorno industriali ed agricoltori producono e mettono sul mercato 100 milioni di dollari di merci e servizi. Produzione, commercio e consumo si ingranano perfettamente. Non esistono disoccupati ... Ad un tratto - in verità le cose si svolgono diversamente per esperimenti vari e successivi; ma debbo semplificare - uno o parecchi uomini di genio inventano qualcosa; e noi industriali - afferma il senatore Agnelli - facciamo a chi arriva prima ad applicare la o le invenzioni le quali permettano risparmio di lavoro e maggior guadagno. Quando le nuove applicazioni si siano generalizzate, risulta che con 75 milioni di uomini si compie il lavoro il quale prima ne richiedeva 100. Rimangono fuori 25 milioni di disoccupati ... Quale la causa? La incapacità dell'ordinamento del lavoro a trasformarsi con velocità uguale alla velocità di trasformazione dell'ordinamento tecnico ... Gli altri 25 milioni, disoccupati, consumano assai meno. La domanda si riduce al di sotto del livello precedente. Dopo un po' basteranno 70 e poi 60 milioni di operai a produrre quanto il mercato richiede. È una catena paurosa... Il danno sembra a me derivare dallo sfaldamento esistente tra due velocità: la velocità del progresso tecnico, il quale ... ha ridotto di un quarto la fatica necessaria a produrre, e la mancanza di progresso nell'organizzazione del lavoro per cui l'operaio continua a faticare le stesse 8 ore di prima. Rendiamo uguali le velocità dei due momenti progressivi, quello tecnico e quello, chiamiamolo così, umano. Poiché per produrre una massa invariata di beni e servizi occorrono 600 invece che 800 milioni di ore di lavoro, tutti i 100 milioni di operai occupati nel primo momento per le 8 ore al giorno, rimarranno occupati nel secondo momento por 6 ore al giorno. Poiché producono la stessa massa di beni di prima, il salario rimarrà invariato in un dollaro al giorno. La domanda operata di beni e servizi resta di 100 milioni di dollari. Nulla è mutato nel meccanismo economico, il quale fila come olio colato. Non c'è disoccupazione, non c'è crisi" [32]. "La tendenza più recente - scrive a sua volta Borsi nella sua "Legislazione del lavoro" [33]- è verso la riduzione della durata del lavoro in considerazione della esuberanza dell'orario attuale di fronte alle esigenze della produzione e della conseguente notevole disoccupazione che affligge in maggior o minor misura quasi tutti i paesi... Fin dal 1934, urgendo in Italia la necessità di limitare il numero dei disoccupati e non potendosi praticamente diminuire in proporzione i salari, si pensò di far regolare la materia, almeno provvisoriamente, mediante contratto collettivo". E, infatti, nell'ottobre del 1934 fu stipulato fra le confederazioni degli industriali e dei lavoratori dell'industria un accordo (noto come "Convenzione Pirelli-Cianetti") - seguito da analoghi accordi delle confederazioni degli altri settori - destinato a "fronteggiare la disoccupazione dei prestatori d'opera nell'industria", col quale si stabilì:
1) che le aziende, che praticavano un orario superiore a quaranta ore settimanali, dovessero, in linea di massima, ridurlo a tale limite;
2) che i salari venissero proporzionati all'orario ridotto;
3) che si costituisse una "Cassa nazionale per assegni familiari", allo scopo di integrare il salario dei lavoratori che avessero famiglia numerosa e che lavorassero ad orario ridotto;
4) che fosse abolito il lavoro straordinario, salvo casi eccezionali dei quali il datore di lavoro era tenuto a dare comunicazione alla propria organizzazione locale entro 24 ore dall'inizio del lavoro stesso;
5) che, dove apparisse necessario e possibile, si sostituisse la manodopera femminile con quella maschile e quella minorile con quella adulta.
La valutazione ufficiale di questo accordo è che "mediante la riduzione della durata della settimana lavorativa l'industria italiana ha già potuto riassorbire oltre duecentomila disoccupati, rivelandosi perciò socialmente utile" [34]. In realtà, la valutazione non può prescindere - oltre che dalla scelta verso la forza lavoro femminile - dalla considerazione della riduzione dei salari operata dall'accordo, solo parzialmente compensata dall'introduzione degli assegni familiari. Puntualmente, Oersted, rappresentante padronale danese alla già richiamata Conferenza internazionale del lavoro e in questa sede uno dei più decisi avversaci dell'accorciamento della settimana lavorativa, replicherà ai delegai Italiani che portavano a sostegno della riduzione a "40 ore" questa esperienza contrattuale: "Credete che la nostra esperienza sarà la stessa di quella che avete fatto in Italia? Mi permetto di avere dei dubbi... I sindacati italiani non prevedono un aumento dei salari. In Italia esiste un sistema estremamente elastico, ed esso non può essere applicato altrove se mancano gli strumenti". E, in realtà, la soluzione adottata è meno garantista delle stesse conclusioni della Convenzione di Ginevra, che, come già ricordato, prevedeva la riduzione dell'orario a parità di salario. Successivamente il regime con il R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, interviene a rendere generale la riduzione d'orario per gli operai dell'industria: questo decreto stabilisce, infatti, il principio che "la durata del lavoro per gli operai che prestano la loro opera alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui in attività di natura industriale non può eccedere le 40 ore settimanali con un minimo di 8 ore giornaliere". Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, che il datore di lavoro possa far eseguire lavoro straordinario (quello oltre le 40 ore) solo in certi limiti e soltanto se non sia in grado di provvedere all'esecuzione del lavoro mediante assunzione di altri lavoratori. Tale provvedimento, comunque - sia perché avrebbe determinato la riduzione dei salari, sia per le esigenze belliche - , non fu attuato: con la legge n. 1109 si sospese "fino a diversa disposizione, l'applicazione del r.d.l. 29 maggio 1937, n. 1768 sulla settimana lavorativa di 40 ore...". Nel contempo si disponeva che "l'orario di lavoro di coloro che prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui è regolato dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti", che è quanto dire il ritorno alla settimana di 48 ore.
5 - La legge del 1923 e i relativi regolamenti di attuazione resteranno così le fonti normative che disciplineranno l'orario di lavoro anche nel dopoguerra. Mentre le possibilità di innovazione legislativa dimostreranno tutte le loro vischiosità, sarà ancora l'azione contrattuale a dover intervenire a limitare gli orari di lavoro. Nell'ambito delle difficoltà generali dell'azione del sindacato nel primo dopoguerra, l'incidenza del controllo sindacale è comunque scarsa. "La durata del lavoro - questa la denuncia di Di Vittorio [35] - viene prolungata ben oltre le 8 ore normali fissate in tutti i contratti di lavoro e ribadite dalla legge, mediante ore di lavoro straordinario. Il fatto che i contributi assicurativi - che sono a carico esclusivo dei datori di lavoro - vengono pagati soltanto sulla base della giornata lavorativa normale e non sul lavoro straordinario, fa sì che il datore di lavoro ha più convenienza ad ottenere da due operai la quantità di lavoro che dovrebbero produrre normalmente 3 operai, pur pagando ai due le maggiorazioni contrattuali sulle 4 ore ciascuno di lavoro straordinario. Il basso livello dei salari, costringendo gli operai a ricercare un guadagno supplementare, attenua la loro resistenza a questa forma brutale di super-sfruttamento. Ne consegue che in molte fabbriche si lavora 60 e anche 72 ore settimanali! Si consideri l'assurdo di una tale situazione, specialmente per l'Italia, paese di grave disoccupazione cronica: invece di stimolare la maggiore occupazione, ripartendo il lavoro disponibile fra il maggior numero possibile di operai, vi è uno stimolo fortissimo alla minore occupazione, costringendo gli occupati ad una fatica sfibrante che logora gravemente la loro salute". In questo quadro, assume notevole rilievo la legge 30 ottobre 1955, n. 1079 (recante modifiche alla legge del 1923 sull'orario di lavoro) .
Questa, infatti, interviene proprio in materia di straordinario, stabilendone il divieto "salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso la assunzione di altri lavoratori". Il provvedimento cerca inoltre, di disincentivarne l'uso aumentandone il costo (con il versamento, a carico dell'azienda di una somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore compiute al Fondo per la disoccupazione) e condizionandolo all'autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del lavoro.
Interessante è leggere la relazione alla Camera del Ministro del lavoro Vigorelli, che esplicita la ratio del provvedimento: "Il fenomeno della disoccupazione è costantemente seguito dal governo nel suo diuturno sforzo teso a contenere fenomeno stesso... A tal fine sono diretti i vari e numerosi provvedimenti, con i quali sono state favorite o realizzate nuove occasioni di lavoro... Ma oltre che con incrementi delle attività produttive, un più elevato livello dell'occupazione può essere realizzato anche senza ricorrere a nuove iniziative, mediante una più adeguata distribuzione delle forze lavorative. È evidente, infatti, che se da un lato si cerca di favorire o addirittura di assumere iniziative per l'assorbimento della manodopera disoccupata, non si può, dall'altro, ignorare o trascurare del tutto la situazione dell'occupazione nelle imprese attualmente esistenti... Sotto tale profilo, si pone il problema del lavoro straordinario, onde determinare se, data la attuale situazione della disoccupazione, sia opportuno o meno consentirne la effettuazione nel settore industriale: in molti casi, invero, all'esecuzione del lavoro si può far fronte invece che con prestazioni straordinarie di personale già occupato, mediante assunzione di altri lavoratori. In siffatte ipotesi, il divieto di lavoro straordinario può apportare un contributo alla soluzione dell'occupazione operaia".
Una politica generalizzata di rivendicazione delle "otto ore" giornaliere e delle "quaranta settimanali" il sindacato riuscirà a farla, con primi risultati concreti, solamente a partire dai primi anni '60. Solo dopo quarant'anni dalla prima contrattazione nazionale degli anni 1919-'20, si ritornerà - con la stagione di rinnovi del '62-'63 - ad un'esperienza generalizzata di riduzione dell'orario normale e straordinario, riduzione assicurata dalla crescita del potere sindacale e non tanto dai risultati concreti della legge del '55 che, se aveva stabilito degli importanti principi, aveva fatto affidamento per la loro attuazione su un organismo inefficiente come l'Ispettorato del lavoro. D'altra parte, proprio la ripresa dell'azione contrattuale sull'orario fa scemare l'interesse del sindacato per una revisione della legislazione in materia [36]. "Tenendo conto della tendenza alla riduzione dell'orario di lavoro, in atto nella vigente contrattazione collettiva, occorre chiedersi - affermano Guidi e Giambarba — se la legislazione, ormai vecchia e superata, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e successivi regolamenti e decreti, costituisca un freno a tale tendenza. Comunque è certo che bisognerà procedere ad una revisione della disciplina giuridica della durata del lavoro" [37]. E l'ipotesi avanzata per tale revisione è la seguente: "la nuova legge dovrebbe soprattutto favorire la tendenza contrattuale in atto. A tal fine essa potrebbe limitarsi a stabilire il termine massimo per l'attuazione in tutti i settori dell'orario settimanale di 40 ore senza riduzione della retribuzione, lasciando ai singoli settori, sul piano della contrattazione sindacale, la possibilità di determinare i tempi anche graduali della riduzione stessa... ".
Questa ipotesi, formulata in una tipica logica di intervento legislativo di sostegno della contrattazione, resterà tale, come allo stato di progetto resterà il disegno di legge - non particolarmente innovativo - formulato dal CNEL nel '67 in materia di orario e riposo settimanale ed annuale. Questo d.d.l. fissa un limite di 45 ore settimanali, in relazione alla circostanza che tale limite era il "traguardo medio della contrattazione collettiva": quindi, avrebbe stabilizzato lo status quo, non accelerando - com'era nell'ipotesi illustrata prima - il raggiungimento delle "40 ore". Per quanto riguarda lo straordinario, il progetto ribadisce il principio della limitazione a due ore giornaliere del lavoro straordinario, introducendo il limite massimo globale di 10 ore giornaliere. L'innovazione, più rilevante, riguarda, comunque, la puntualizzazione della funzione delle organizzazioni sindacali in ordine alla effettuazione dello straordinario: il controllo sul suo svolgimento non viene più affidato alla competenza esclusiva dell'Ispettorato del lavoro, essendo previsto un ruolo attivo del sindacato nel promuovere l'intervento dell'Ispettorato perché ne sia disposta la cessazione o limitazione nei casi vietati (sostanzialmente quelli già previsti dalla legge n. 1079 del 1955).
A conclusione (con la conquista delle "40 ore") dell'azione rivendicativa avviata agli inizi degli anni '60 e in mancanza di nuovi interventi legislativi, la distanza fra regolamentazione legislativa e normativa contrattuale risulta ormai massima, secondo un rapporto che va oltre i progressi che i contratti hanno realizzato rispetto alla legge derogandola in melius [38].
A causa di espresse disposizioni contrattuali, infatti, il limite dello orario normale resta per gli effetti legali a 48 ore: la conseguenza è che restano bloccati tutti i meccanismi legislativi di controllo dello straordinario.
Una nuova (e, da parte del movimento sindacale, preoccupata) attenzione verso la possibilità di un intervento legislativo in materia di orario è stata da ultimo suscitata dalle "Considerazioni finali e proposte" della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "giungla retributica".
L'orario di lavoro, Infatti, rientra fra gli istituti su cui la Commissione ipotizza l'opportunità di un intervento legislativo con funzione di determinazione di livelli di trattamento non derogabili in meglio dalla contrattazione (per l'orario di lavoro, anzi, la Commissione individua, già in sede di proposte, il limite di un "orario settimanale di 40 ore per tutte le attività", con la conseguenza che si dovrebbe avere "una riduzione per i settori che hanno ancora un orario maggiore, e anche un aumento dell'orario por i settori attualmente ad orario inferiore, non giustificato da particolari esigenze tecnico-produttive e organizzative da prevedere come eccezioni"). Non è difficile rilevare come questa prospettiva legislativa sia radicalmente in contrasto (per il problema specifico dell'orario e per il rapporto che, in generale, verrebbe ad instaurare fra "legge" e "contratto") con l'impostazione propria del movimento sindacale. In questa sede giova sottolinearne anche l'abnormità giuridica o, meglio, l'evidente incostituzionalità: il principio di libertà sindacale (art. 39, I comma, Cost.) contiene, infatti, anche la prerogativa del sindacato di disporre in piena autonomia della contrattazione collettiva [39].
La richiamata ipotesi di legislazione sull'orario è stata, comunque, parzialmente corretta già dal parere che il CNEL ha, appunto, reso nel novembre del 1977 sulle conclusioni della "Commissione Coppo". In generale, il CNEL, ha infatti, escluso la possibilità che "nell'ambito del nostro sistema normativo, siano stabilite con legge condizioni retributive e normative non suscettibili di deroghe migliorative da parte dell'autonomia privata come dell'autonomia collettiva". Per quanto, invece, più direttamente riguarda l'orario il parere formulato in sede di CNEL ha confermato l'opportunità di un intervento legislativo di generalizzazione delle 40 ore. Esso, inoltre, sembra muoversi - nonostante le premesse prima ricordate - in una prospettiva di assunzione di questo orario come un trattamento "definitivo", anche se - e qui si ritrova una interessante ammissione - il parere del CNEL ammette fra le "ragioni plausibili" che potrebbero giustificalo lo scendere al di sotto dello 40 ore, anche quelle "di ordine occupazionale". L'ultimo intervento legislativo in cui il rapporto orario-occupazione è emerso è quello (del dicembre 1977) relativo alla parità uomo-donna. Fra gli obiettivi di questa legge - sulla cui efficacia pratica più di un dubbio è legittimo — c'è l'aumento dell'occupazione delle donne. A tal fine, uno dogli strumenti utilizzati è la possibilità di una diversa gestione del tempo di lavoro nei confronti della forza-lavoro femminile [40]: per questa il divieto di lavoro notturno è portato (nelle aziende manifatturiere, anche artigianali) dalle ore 24 alle 6 (anziché dalle 22 alle 5). Non affrontando qui la questione relativa al come utilizzare questa previsione legislativa (tenendo, in ogni modo, presente che è data alla contrattazione collettiva la facoltà di disciplinare diversamente il divieto), va sottolineato come sia significativo che anche la legge colga (qui non in una prospettiva di riduzione) il rilievo che la gestione del tempo di lavoro (non solo per la sua durata giornaliera ma anche per la sua collocazione durante le 24 ore) può assumere per la partecipazione delle diverse componenti delle forze di lavoro alle opportunità occupazionali.
Note
[1] Alessandro Dalla Volta, La riduzione delle ore di lavoro ed i suoi effetti economici, Bocca, Firenze 1891.
[2] Emilio Cossa, La diminuzione delle ore di lavoro, Milano, Vallardi, 1982.
[3] Regolamento di fabbrica delle Officine di Trezzo d'Adda Perego e Zuhlke, Milano (1909), pag. 9.
[4] Altri dati - riportati da Stefano Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale, Firenze, pag. 197 e segg - illustrano una realtà di sfruttamento ancora più pesante.
[5] Lo rileva Gaetano Veneto, Contrattazione e prassi nei rapporti di lavoro, Bologna, 1974, pag. 153, che riporta quanto affermato da Ludovico Barassi ne Il contratto di lavoro, pag. 478.
[6] Antonio Cabrini, Leggi sociali e lotta di classe, Roma, 1901, pag. 7.
[7] La legge del 1886 (che non regolava ancora il lavoro delle donne) fissava, inoltre, a nove anni l'età di ammissione al lavoro; proibiva il lavoro notturno solo per i minori di 12 anni. Oltre a prevedere numerose possibilità di eccezioni e di deroghe - per necessità tecniche - ai pochi limiti imposti allo sfruttamento dei minori, erano sottratti alla disciplina legale (tramite la nozione di "opificio") non solo le piccole industrie, i laboratori, il lavoro o domicilio, ma anche Industrie (come l'edilizia) che utilizzavano largamente i minori in lavori faticosi e insalubri.
Per più ampie indicazioni e per ulteriori note bibliografiche, si veda Maria Vittoria Balestrero, Occupazione femminile e legislazione sociale in Quaderno della Rivista giuridica del lavoro, n. 1, luglio 1977.
[8] La legge prevedeva, infatti, che l'abolizione del lavoro notturno per le donne di qualsiasi età non potesse essere sancita che cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
[9] Così S. Merli, op. cit., pag. 484.
[10] Per queste osservazioni si veda Silvano Levrero, Fasi storiche internazionali della lotta per la riduzione degli orari, in Quaderni di Rassegna Sindacale, n. 26, giugno 1970, pag. 49 e segg.
[11] Vedi le richiamate in Merli, op. cit. pag. 510 e segg.
[12] I problemi del lavoro, 1903, nn. 3-4.
[13] Così Maurizio Carbognin, La ristrutturazione nel settore dei giornali quotidiani, in Contrattazione n. 3, luglio 1975.
[14] In Bollettino dell'Ufficio del lavoro, Vol. IV, 1905, pag. 229.
[15] In Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, vol. XXIV, luglio-dicembre 1915, pag. 263.
[16] In Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, Vol. XXXIV, luglio-dicembre 1920, pag. 130.
[17] In Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, Vol. XXXIV, luglio-dicembre 1920, pag. 168.
[18] G. Veneto, op. cit., pag. 156.
[19] Per più ampie notizie su questa lotta e per il quadro di posizioni in cui si colloca, si veda Levrero, op. cit., pag. 50.
[20] Peraltro, già prima della fase dei contratti collettivi nazionali, i sindacati si erano impegnati ad elevare il costo del lavoro straordinario. "Per lo più le leghe domandano il doppio della mercede oraria normale": così scriveva Barassi, portando ad esempio l'art. 5 del memoriale rivendicativo dei muratori, inviato al collegio dei capomastri a Milano, del 17 febbraio 1910. Inoltre, sempre Barassi riportava, come esempio altrettanto significativo, il progetto di legge sul contratto di impiego privato che, all'art. 11, prevedeva il diritto ad "un maggior compenso in caso di lavoro straordinario in misura superiore almeno di un terzo a quella di servizio ordinario" Sul primo punto, va ricordato che sarà la stessa ROM a constatare carenze di applicazione delle otto oro e a includere ancora la questione nel memoriale rivendicativo inviato agli industriali nel maggio del 1920.
[21] Sul secondo aspetto, va ricordato quanto sottolineato significativamente dal Rigola: nel dopoguerra il sindacato si trovava di fronte all'alternativa tra battersi per le 8 ore o battersi contro le forme di "organizzazione scientifica del lavoro ed il taylorismo".
I sindacati "hanno rinunciato - continua Rigola - per le 8 oro alle pregiudiziali contro il taylorismo e l'organizzazione scientifica del lavoro che prima della guerra rimanevano intatte".
[22] Così Veneto, op. cit., pag. 158, che fra l'altro trae queste osservazioni da un'analisi dei concordati riportati nel Bollettino del lavoro del periodo.
[23] Per più ampie informazioni sull'attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di durata del lavoro, si può vedere L. Paloscia, "La disciplina della durata del lavoro nella sua evoluzione legislativa", in Lavoro e sicurezza sociale, n. 2, 1967, pag. 177 e segg.
[24] Così Lello Gangemi, Il problema della durata del lavoro, Firenze 1929, pag. 253.
[25] Oltre al già richiamato concordato dei meccanici, vanno considerati, ad esempio, i contralti del settore della lana [17 luglio 1920): straordinario con "carattere eccezionale" e retribuito col 40% nei giorni feriali e 80% nei festivi; quello del settore della juta (17 aprile 1920): straordinario non superiore alle 6 ore settimanali e con aumenti retributivi uguali a quelli previsti per il settore laniero; il contratto dei cotonieri (7 aprile 1920): otto ore di straordinario al massimo per settimana, 30% di incremento retribuivo per le prime due ore, 60% per le altre tre, 100% per le successive; quello degli elettrici (28 luglio 1920): otto ore al massimo per settimana, con maggiorazione del 50% per le prime quattro ore e del 100% delle successive; e ancora, quello dei chimici (6 giugno 1919 e 20 novembre 1920): otto ore al massimo di lavoro straordinario con le stesse maggiorazioni previste per I gasisti, che hanno le stesse degli operai meccanici.
[26] Si veda, a questo riguardo, la circolare 30 dicembre 1923, n. 19, del Ministero per l'economia nazionale, in Bollettino del lavoro, n. 1, luglio 1923, pag. 476, che elenca 6 tipi di deroghe.
[27] Per le considerazioni e i riferimenti riportati nel testo e una approfondita analisi delle conseguenze della "razionalizzazione", si veda Giulio Sapelli, Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell'Italia tra lo due guerre, Torino 1978, pag. 32 e segg.
[28] In F. Maurette, La Conféerence préparatoire pour la semaine de quarante heures, B.I.T., 1933, pag. 315.
[29] Conférence internationale du travail, dix-neuvième session, Compte rendu des travaux, pagg. 73-74, BIT, Genève 1935.
[30] In Conférence internationale du Travail, cit., pag. 152 e segg.
[31] La riforma sociale, n. 1, 1933.
[32] La replica di Einaudi, e la controreplica di Agnelli sono sempre riportate in La riforma sociale, n. 1, 1933.
[33] U. Borsi, op. cit., pagg. ence internationale du Travail, cit., pag. 152 e segg.
[33] La riforma 146-148.
[34] Così U. Borsi, op. cit., pag. 151.
[35] G. Di Vittorio, Supersfruttamento e produttività nell'industria, in Rinascita, 1951, n. 5.
[36] Un tentativo per rivitalizzare l'interesse degli organismi internazionali sulla questione dell'orario e quindi della legislazione nazionale e, comunque, rappresentato dall'Iniziativa della CISL di sottoporre la questione delle "40 ore" all'esame del Consiglio di amministrazione del BIT, nella sua 13a sessione del 1957.
[37] Così E. Guidi - E. Giambarba: "I contratti nazionali di categoria (1955-'63)", Roma, 1966, vol. I, pag. 367.
[38] Per l'analisi dei rapporti "legge" e "contratto" in tema di orario, si veda Mario Napoli, Problemi legislativi connessi alle trasformazioni d'orario, in Prospettiva sindacale, n. 3, settembre 1978, pag. 144 e segg.
[39] A questo riguardo si veda, fra gli altri contributi, Salvatore Mazzanuto - Paolo Tosi, Il costo del lavoro fra legge e contratto, in Rivista giuridica del lavoro, n. 2/1977, pag. 230 e segg.
[40] Per un'analisi più approfondita di questo principio, si veda A. Andreoni, G. Arrigo, P. De Luca, R. Maffei, A. Pandolfo, G. Napolitano, La parità. Commento alla legge, Roma 1978, pag. 57 e segg.