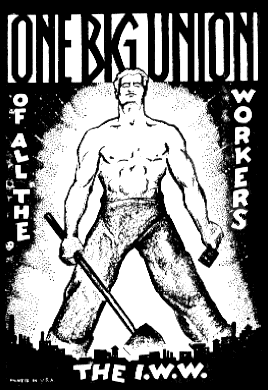Introduzione di una fotografia
 Sono all'incirca una ventina gli uomini che una vecchia fotografia ha ritratto in un cortile polveroso. Vestono giubbe da lavoro e camicie senza colletto, hanno nel complesso quell'aria dimessa, quasi vergognosa, che sempre avevano allora gli umili quando venivano immortalati in una fotografia. Nessuno tra di loro infatti guarda verso l'obiettivo.
Sono all'incirca una ventina gli uomini che una vecchia fotografia ha ritratto in un cortile polveroso. Vestono giubbe da lavoro e camicie senza colletto, hanno nel complesso quell'aria dimessa, quasi vergognosa, che sempre avevano allora gli umili quando venivano immortalati in una fotografia. Nessuno tra di loro infatti guarda verso l'obiettivo.
La prima fila è seduta per terra e tutti tengono le gambe incrociate e le braccia appoggiate sulle ginocchia, le dita delle mani intrecciate tra di loro. La seconda fila è in piedi e gli uomini hanno le braccia ai lati del corpo, quasi assumere una postura diversa volesse significare uno sforzo che non sono più in grado di sostenere. Due soldati col berretto duro e gli stivali in dotazione, di chi viene arruolato in cavalleria, guardano dentro l'obiettivo e intanto tengono le corte carabine bilanciate tra le braccia. Un ufficiale se ne sta ritto tranquillamente davanti a tutti.
Gli uomini ritratti di lì a poco saranno fucilati, ma questo ovviamente la fotografia non lo può raccontare.
Quando venne il loro turno, con un cenno sbrigativo della mano, l'ufficiale spedì quegli uomini davanti a una fossa che conteneva tanti dei loro amici, alcuni ancora scossi dai brividi irrefrenabili dell'agonia.
Quelli si misero in fila davanti al plotone di esecuzione e attesero la scarica che li avrebbe ammazzati.
Poi un ufficiale passò sul bordo della fossa comune e sparò nella testa a quelli che ancora si muovevano.
Allora la fossa venne colmata da alcuni soldati che certamente sudarono malgrado l'eterno vento che soffia sulla pampa. E fu tutto finito.
In quel modo ne vennero ammazzati due o tremila. Nessuno ha mai saputo in realtà quanti essi furono.
Si era in Argentina nell'anno di grazia 1921, in una landa desolata dell'emisfero australe.
In Patagonia
"PAMPA": nome locale usato specialmente nell'America Meridionale con il quale si designano le pianure prive di boschi, comprese tra le Ande cileno-argentine e l'Oceano Atlantico; in senso più ristretto in questo vastissimo territorio si dà il nome di pampas alle zone rivestite da una vegetazione quasi esclusivamente di graminacee".
(dal Dizionario Enciclopedico Italiano)
"Partono i bastimenti per terre assai lontane", così cantavano alla fine dell''800, con commossa partecipazione, i cantastorie nella piazza del mercato, anche del più sperduto paesetto d'Italia. E i bastimenti partivano ogni giorno per davvero dal porto di Genova con il loro carico di carne umana.
Erano stracolmi soprattutto di contadini veneti e di "cafoni" calabresi. Emigravano perché nei loro paesi arroccati come vecchie fortezze sul culmine delle colline, o nei "casoni" persi tra le canne e le paludi del delta del Po" non c'era di che vivere.
Non sapevano certo che erano costretti ad andarsene perché le speculazioni della borsa avevano distrutto le già fragili economie delle regioni in cui vivevano, per loro emigrare faceva parte del destino, così come una gelata fuori stagione ti distrugge il raccolto. Erano, quelle, soltanto braccia in eccesso, e non a caso il governo Giolitti, pur di liberarsi di quei miserabili, pagava loro per intero il biglietto del piroscafo.
Quand'erano al largo, a volte, incrociavano navi cariche di carne e di frumento che dalle americhe "puntavano" i porti europei. Quelle navi portavano cibo a buon mercato, indispensabile per nutrire i milioni di operai che la seconda rivoluzione industriale impiegava in quei grandi stabilimenti che sorgevano un po" dovunque e che avrebbero cambiato per sempre il paesaggio dell'Europa intera.
A volte invece affiancavano navi cariche di "cafoni" che venivano dalla Galizia, dalla Mancha o dall'Andalusia, come loro, diretti in Argentina.
Tutti poi arrivavano a fiumane nel porto della Boca, non a caso in pochi anni Buenos Aires, che già misurava 137 chilometri quadrati, quella città dalla pianta a scacchiera, le piazze amplissime, le vie lunghe e diritte, era diventata la terza città di lingua spagnola del mondo intero, e una delle prime città abitate da italiani.
Loro si accalcavano all'Avellaneda, ai Docks Sud, a San Martin, o in uno di quei quartieri che sempre toccano ai poveri.
Trovavano lavoro per un salario miserabile nei giganteschi mattatoi, a costruire palazzi, nelle ditte che inscatolavano carne, a risanare le paludi che la città nel suo sviluppo vorace divorava ogni giorno.
Chi non trovava lavoro in quella città enorme doveva andarsene nella "pampa". Perché l'Argentina era divisa in due: da una parte la capitale, dall'altra quel mare d'erba che era legale possesso delle grandi famiglie inglesi e gallesi i quali avevano "estancias" che per la loro estensione facevano impallidire gli immensi latifondi dell'Andalusia. Degli inglesi erano la terra, le ferrovie, la nascente industria, le banche e ogni altra cosa.
La "pampa" rappresentava la frontiera del profitto, da quando le truppe della repubblica argentina avevano ucciso nel 1880 l'ultimo degli indigeni "araucani", in uno dei più totali e definitivi massacri di popoli che la storia ricordi.
Da lì, da quelle pianure, dove l'erba cresceva più alta di un uomo a cavallo, veniva la vera ricchezza della repubblica, di quello stato che si reggeva sull'alleanza tra i grandi proprietari terrieri, la chiesa e l'esercito, che non a caso un giornalista anarchico, con felice sintesi, aveva chiamato la sacra alleanza tra la "vacca, la croce e la spada".
In quella terra benedetta da Dio, dove le vacche si riproducevano a milioni, le giornate di lavoro andavano dalle quattro del mattino alle undici di sera passate a caricare su un carro merci sacchi di ottanta chili l'uno, i contadini scoprivano subito che non potevano mai fermarsi, anzi dovevano lavorare a trotto sostenuto, che il vento faceva loro volare in faccia tutta la terra e le foglie d'intorno.
I sacchi di grano e di riso venivano caricati su carri su cui si saliva per una stretta passerella di legno e poi si levavano nelle stive piramidi alte come colline.
E tutto questo per un salario miserabile, che non veniva nemmeno pagato ogni giorno, com'era invece costume fare nei porti. Anzi i "capataz", quasi sempre ex operai, odiatissimi dai braccianti, pagavano soltanto la domenica e davano agli operai quello che volevano loro.
Il cibo consisteva ogni giorno in carne di pecora e in una minestra di galletta e di riso. E anche qui, come nei "pueblos andalusi", il potere era nelle mani dei "capataz" e dei politici locali quasi sempre conservatori, e ogni minima protesta degli operai subito veniva comunicata alla polizia.
La sera in quegli accampamenti che sorgevano accanto alla linea ferroviaria, coi binari che correvano sempre verso Buenos Aires, gli operai, malgrado fossero spezzati da una giornata di lavoro massacrante, si facevano un punto d'onore nell'andare ad ascoltare il delegato sindacale o uno delle "lingheras", che tutti chiamavano così perché gli averi di quegli uomini dai capelli e la barba lunghi stavano tutti nelle sacche di stoffa che portavano alla tracolla. Quegli uomini che sempre arrivavano in primavera sapevano leggere e scrivere e portavano nelle stinte bisacce di tela copie degli scritti di Malatesta, che nella pampa era andato a cercare l'oro, o articoli della "Protesta", il giornale che la FORA editava e sosteneva nella capitale.
In quelle "tertulias" non si beveva alcool, era ammessa soltanto acqua di sorgente o di pozzo e si parlava di tutto: del tradimento che i bolscevichi avevano fatto della rivoluzione, della necessità di eliminare qualsiasi forma di stato e di educare i propri figli a non diventare soldati o poliziotti, "Siete esseri umani non bestie da soma, siete uomini che meritano rispetto e dovete lottare per vivere con dignità. Chi lotta per il pane deve leggere e pensare in modo collettivo. Perché se la lotta economica è necessaria più importanti ancora sono i valori morali, la conquista e la difesa della Libertà". Così veniva detto loro. Poi, dopo qualche giorno, i "lingera" ripartivano e si spostavano in un altro accampamento distante magari centinaia di chilometri.
In questo modo si gettarono i semi per la nascita di un sindacato: la Federación Obrera Regional Argentina, uno dei sindacati più dimenticati, originali e combattivi nella storia del movimento operaio del mondo intero.
La FORA viene costituita a Buenos Aires nel 1901 su impulso degli anarchici italiani come di quelli spagnoli e, tanto per chiarire la sua natura, in un solo anno del governo di Hipolito Yrigoyen, il presidente che non usa mai il telefono, scatena a Buenos Aires 367 scioperi con tanto di attentati alle panetterie che non rispettano le norme relative al lavoro notturno e sabotaggi ai tram.
La Fora, odiatissima nei saloni del "Jockey Club", che è il luogo deputato agli affari dell'oligarchia "boranense", è capace di resistere anche ai colpi più duri, come accadde durante la "Semana Tragica" del 1919.
In quei giorni, siamo nel gennaio del 1919, parte uno sciopero alla "Vasena", una fabbrica metallurgica. Gli operai chiedono che la giornata lavorativa scenda da 11 a 8 ore e che la domenica sia festa. Quando si concentrano in Piazza Martin Fierro per dare vita a una manifestazione vengono attaccati dalla polizia. Quattro morti e trenta feriti. Il nove di quello stesso mese, in seguito a uno sciopero generale per permettere a tutti di assistere ai funerali delle vittime, davanti al cimitero delle Chacarita, che tutti chiamano la "Città dei morti", la polizia apre ancora il fuoco. Questa volta i morti sono otto, almeno a dar retta ai rapporti della polizia, più di cinquanta invece per "La Prensa, giornale certamente non tenero con gli anarchici.
Ma il peggio deve ancora arrivare. Infatti il quattordici di gennaio gli uomini della "Liga Patriotica Argentina" di Carlos Prestes, assieme a reparti dell'esercito comandati dal colonnello Luis Delle Piane attaccano i quartieri operai aprendo la caccia ai "judios", come chiamano gli immigrati russi polacchi e tedeschi. Alla fine di quella settimana i morti accertati sono ottocento, più di quattromila i feriti. Tra gli ufficiali che si distinguono in quella mattanza c'è un giovane tenente che si chiama Juan Domingo Peron. In una fotografia che appare su "La Prensa" a commento di quei fatti, tra i soldati a cavallo cammina tranquillo, quasi la cosa non lo riguardasse, Kurt Wilchens, che ritroveremo in questa storia.
E' a questo sindacato, e non poteva in fondo essere altrimenti, che i braccianti della pampa e della Terra del Fuoco si rivolgono per vedere riconosciuti i loro diritti.
La Fora spedisce subito a Santa Cruz, che era allora un centro di produzione della lana che partiva per l'Inghilterra, Antonio Soto, "El Gallego", uno dei suoi organizzatori più capaci.
Antonio Soto, che è nato a El Ferrol nel 1897, è un bracciante lui stesso, anche se ama vestire con una certa eleganza. In una foto infatti appare con l'abito scuro, camicia bianca, la cravatta svolazzante al vento, berretto floscio da autista di piazza e gambali da cavallerizzo. Il viso abbronzato di chi è abituato a lavorare all'aria aperta. Arrivato a Rio Gallego capisce subito che la partita che si giocherà in quel posto che pare perso in fondo a un deserto è fondamentale per lo sviluppo economico di tutta l'Argentina. In quel piccolo centro infatti arrivano i prodotti degli immensi latifondi della provincia di Santa Cruz: carne e lana soprattutto.
Ma con la fine della Prima Guerra Mondiale il prezzo della lana è calato dei due terzi, visto che l'industria tessile inglese, che tradizionalmente acquista quegli enormi stock di lana, comincia a rivolgersi al mercato della Nuova Zelanda e dell'Australia dove l'allevamento del bestiame avviene ormai con metodi razionali. E questo rischia di mettere fuori gioco la produzione argentina.
Così l'oligarchia si rende conto che rischia di perdere quel mercato dove per decenni ha agito in regime di monopolio.
Gli "estanceros" devono trasformarsi in industriali e i capitali indispensabili per l'industrializzazione di quell'immenso paese devono venire per forza dalla pampa. Così i braccianti cominciano ad essere pagati in buoni acquisto o in moneta straniera, in modo tale che i loro salari perdano valore con il cambio. La giornata lavorativa viene allungata e soprattutto i braccianti, per aumentare la produzione, vengono costretti a un cottimo continuo.
Antonio Soto ascolta le richieste e le aspirazioni degli operai, si rende subito conto che è indispensabile unire nello stesso sindacato gli uomini che lavorano nelle estancias, quelli dei mattatoi, gli scaricatori e gli addetti alle celle frigorifero grandi come campi da calcio. Inoltre sa quanto sia importante far uscire dal loro isolamento gli operai delle gigantesche estancias dell'interno e mettere in discussione quel legame di tradizionale subordinazione e rispetto che sempre lega il bracciante al padrone. Inizia così una fitta corrispondenza con "La Protesta" e i braccianti, stupiti, vedono apparire su quel giornale le loro richieste. Capiscono così che laggiù, nella capitale, che è sempre apparsa più lontana di Marte, c'è chi si occupa di loro.
Lo sciopero "parte" nel Settembre del '20 e inizia con il boicottaggio di tre empori di proprietà della "Sociedad Rural" che praticano dei prezzi da strozzo, addirittura con ricarichi del millecinquecento per cento sulle merci vendute. Il boicottaggio riesce alla perfezione.
E' a questo punto che Antonio, che la polizia ha già arrestato e torturato e gli uomini degli "estanceros" hanno cercato di uccidere, presenta alla Sociedad Rural l'elenco delle proposte dei braccianti per interrompere il boicottaggio.
Tra l'altro nel documento si legge che i braccianti debbano dormire in non più di tre in sedici metri quadri, l'astensione dal lavoro il sabato, salario minimo a cento pesetas al mese e riconoscimento della Fora come unico interlocutore.
I padroni, che ritengono inammissibili quelle richieste, si rifiutano e allora, seguendo una tattica collaudata, si scende in sciopero.
Lo sciopero che è partito da Rio Gallego si estende a tutte le estancias e i padroni rimangono subito stupiti della compattezza e della decisione degli operai agricoli. Uno sciopero che diventa totale, generale e a tempo indeterminato, a partire dai primi giorni di novembre.
Si sciopera infatti a Buitreras, Alquinta, Rincon, Los Morros, Glen Cross, La Esperanza e La Anita. Antonio Soto, da parte sua, alza sulla estancia Bella Vista la bandiera rosso e nera dell'anarcosindacalismo.
Addirittura Alfredo Fonte "El Toscano" e il suo socio il "68" con un gruppo di uomini che portano un bracciale rosso di stoffa legato al braccio assaltano l'estancia "El Campamento" al Lago Argentino e prendono prigionieri i proprietari con le loro famiglie.
Soto organizza inoltre colonne di operai per rompere l'accerchiamento a cui gli uomini della "Guardia Blanca", vera e propria milizia privata degli estanceros, prevedibilmente li sottoporranno. E da tutte le estancias lunghe colonne di uomini si dirigono verso Rio Gallego.
E' a questo punto che la "Sociedad Rural" accetta di trattare, e incredibilmente i padroni cedono su tutto. Ma quella è soltanto una mossa per guadagnare tempo. I proprietari terrieri infatti aspettano che arrivi nella zona il 10 Cavalleria, seicento uomini comandati dal colonnello Varela che dal presidente Yrigoyen ha ricevuto il semplice ordine: "Vada e compia il suo dovere".
Varela arriva nella provincia di Santa Cruz accolto in maniera entusiastica dai proprietari terrieri il 10 novembre.
Subito il governo cileno collabora con lui chiudendo i passi di frontiera e il giorno stesso Varela ordina la prima fucilazione. l'operaio messo al muro, ironia della sorte, è un cileno che si chiama Trivino Garcano.
Soto cerca di evitare a tutti i costi lo scontro con i reparti dell'esercito. Sa benissimo infatti che l'esercito argentino, fin dai tempi del generale Rosas y Rosas, ha una consolidata tradizione di massacri.
Nel 1905 a Springhill, nella Terra del Fuoco, tutta una tribù è stata infatti sterminata con la carne di una balena che è stata "lardellata" con della stricnina. A Playa de Santo Domingo quattrocento indigeni sono stati ammazzati, uomini, donne e bambini per avere rubato delle pecore. Altri massacri si sono avuti nel Chaco e a Napalpi, senza contare i tanti dei quali non si è avuta notizia alcuna.
E' per questo motivo che Soto dà l'indicazione agli scioperanti di disperdersi in quel territorio immenso. Spera così che molti di loro potranno salvarsi. Ma non ha fatto i conti con la feroce determinazione che metteranno i soldati nello sterminare chi ha osato ribellarsi. Quella determinazione che mai l'esercito argentino ha messo nelle guerre che ha combattuto, Falkland-Malvinas compresa. Dove il fior fiore dei suoi reggimenti si arrese in meno di quarantotto ore alle compagnie dei Gurkas inglesi.
Inoltre gli uomini, in quelle assemblee su cui aleggiano la disperazione e la paura, argomentano che i soldati hanno dato la loro parola d'onore che non succederà nulla a chi si arrenderà, e la "parola di un militare varrà pure qualcosa", e preferiscono concentrarsi in quelle estancias dove hanno lavorato per anni. E aspettare.
I soldati prendono prigionieri ottanta uomini e subito ne fucilano la metà. Dopo un regolare processo, ben s"intende.
E' a questo punto che il capitano Vinaz Ibarra attacca Soto alla estancia La Anita, fucila subito gli emissari che gli operai hanno mandato a parlamentare, poi fa sapere che loro dovranno arrendersi senza condizioni. l'assemblea degli operai, circa duecento, decide di capitolare malgrado il disperato parere contrario di Soto che dice: "Non sono carne per i cani", e assieme a dodici compagni attraversa di nascosto la frontiera col Cile al Cerro Centinala.
Si perde nelle Ande e si salva anche "El Toscano" assieme ai suoi uomini. Gli altri che rimangono vengono tutti passati per le armi, anche se i soldati dichiareranno che i morti sono stati appena due.
Si fucila all'estancia Bella Vista, sul Rio Chgico e a Canada Leon, alla stazione di Tehuelches e a quella dello Jaramillo. Gli operai sono annichiliti al Cerrito come al Canadon de la Yegua Quremada e Al Paso Ibanez.
Intanto la polizia assieme agli uomini della Liga Patriotica devasta le sedi sindacali di Rio Gallego, Puerto Deseado, San Julian, Puerto Santa Cruz. Gli squadroni si muovono per tutta la provincia.
Quando localizzano gli scioperanti mandano sempre degli emissari assicurando che non ci saranno rappresaglie indiscriminate. Chiedono che gli operai consegnino le armi, quasi esclusivamente coltelli e pistole, e liberino i padroni che sono stati sequestrati, ai quali del resto non è stato torto un capello. Quando le loro richieste vengono esaudite, organizzano i plotoni d'esecuzione.
Spesso viene ammazzato anche chi non ha avuto nulla a che fare con lo sciopero. Cadono infatti pecorai, mandriani e contadini che hanno avuto soltanto la sfortuna di capitare su una pattuglia dell'esercito.
L'ultimo gruppo ad essere intercettato dall'esercito è quello diretto da Facon Grande, un gaucho abilissimo nella doma, che vestiva sempre coi pantaloni tipici dei "gauchos" e portava due coltelli incrociati in una fascia di seta nera che gli faceva da cintura. Facon non ha certo cara l'iconografia argentina che vuole il "gaucho" come paradigma del vero argentino. Buono in fondo soltanto a bere "mate", a cantare la sera attorno a un fuoco perso nella "pampa" strazianti canzoni che parlano di tradimenti e di amori tragicamente finiti e a mangiare gigantesche porzioni di "asado". Fin da subito lui si schiera dalla parte degli scioperanti e capisce che è fondamentale il controllo della ferrovia. Ed è infatti sulla stazione di Jaramillo che marcia con circa 400 uomini. Ma viene intercettato. Varela in persona dà la sua parola che chi si arrende non subirà rappresaglia alcuna. Facon Grande sa benissimo che Varela, quel soldatino di piombo che una fotografia ritrae con il colbacco, il "dolmen" degli ussari, le mani guantate poggiate sull'elsa della spada, non manterrà nessuna delle promesse che ha fatto. Ma non ha alternative. Così a cavallo, accompagnato da un amico, si dirige al passo verso la fila dei soldati che lo stanno aspettando.
Appena arriva a pochi metri da dove sono posizionati i cavalleggeri, senza neanche fargli aprire la bocca, questi lo crivellano di colpi con il loro "mauser" d'ordinanza, mentre lui non è ancora sceso da cavallo.
Per sette giorni i cadaveri dei due rimasero nella polvere a 500 metri dalla stazione di Jaramillo. Il cadavere di Facon Grande teneva stretto in una mano un asso di picche che, per irrisione, qualcuno gli aveva messo tra le dita. L'altra gli era stata tagliata da amici che la conservarono in una teca di vetro, immersa nella formalina. Assieme a lui furono fucilati in più di sessanta. A quel punto fu tutto finito.
Il primo gennaio del 1922, all'Hotel Argentina di Puerto Gallegos, la Sociedad Rural festeggia l'anno nuovo annunciando che i salari dei braccianti sono stati ridotti di un terzo.
A quella festa ci sono andati proprio tutti: i grandi proprietari terrieri che ormai, passata la paura, pregustano il ritorno dei "buoni tempi andati", quando operai e padroni andavano d'accordo, ben s"intende nel rispetto dei rispettivi ruoli. Partecipano ai festeggiamenti anche gli inviati dei grandi quotidiani della capitale, Carles in persona, che è arrivato su una nave quel giorno stesso, lo stato maggiore di Varela al gran completo e i politici conservatori ma anche quelli radicali del partito di Yrigoyen.
Si brindò molte volte con champagne rigorosamente d'importazione durante quella festa sontuosa, l'orchestra oltre che valzer, polke e altri ballabili suonò innumerevoli volte l'inno nazionale, sempre cantato dai presenti con compunta commozione. L'unica nota stonata in quella festa bellissima si ebbe quando cinque puttane del vicino postribolo de "La Catalana", che erano state convocate, si rifiutarono di darsi ai maschi scapoli presenti. Una di loro anzi gridò: "Siamo delle puttane, ma non scopiamo con degli assassini", frase che suscitò stupore e riprovazione fra tutti i presenti, signore ingioiellate comprese. Ma probabilmente le puttane avevano bevuto troppo e non sapevano cosa andavano dicendo.
Epilogo. Buenos Aires 25 Gennaio 1923
Kurt Gustav Wilckens in quell'anno ha trentasette anni e l'aspetto da attore holliwodiano di un film di Fritz Lang. Tolstojano, convinto pacifista, vegetariano, corrispondente da Buenos Aires per giornali operai tedeschi e scaricatore portuale, da alcuni giorni, per la prima volta in vita sua, gira armato per le strade della città.
Aspetta Varela in calle Fitz Roy al numero 2461, nel rione Palermo, dove il colonnello abita con tutta la sua famiglia. Quel giorno, a differenza del solito, il colonnello esce da solo, e Kurt prima gli scaglia in mezzo alle gambe una bomba a mano, e poi lo finisce con cinque colpi di rivoltella. Sul corpo del colonnello verranno contate ben diciassette ferite, cinque di proiettili e dodici attribuibili alle schegge di una bomba a mano.
L'ultimo colpo che è rimasto nel tamburo Kurt se lo tira nel petto, ma si ferisce in modo superficiale. Ai poliziotti che lo arrestano dice soltanto: "Aveva ucciso i miei fratelli".
Kurt viene ammazzato in carcere da Perez Millan Temperley. L'ufficiale che è iscritto alla Liga Patriotica di Carles gli spara con un fucile di grosso calibro mentre lui dorme rinchiuso in una cella. Poi si fa fotografare in posa da cacciatore di cacciagrossa, il piede sul petto dell'anarchico, la carabina col calcio appoggiato all'anca.
Una perizia medica compiacente fa passare per pazzo Perez Millan che viene così inviato nel manicomio di calle Vieyetes di Buenos Aires. Se Perez finisse in carcere potrebbe essere ucciso da uno dei tanti anarchici lì rinchiusi, così ragionano i suoi difensori, poi, calmate le acque, si potrà vedere di far tornare in libertà un patriota come lui. Non lo sanno ma all'ufficiale restano appena due anni scarsi di vita.
Wladimirovich, un anarchico russo che è finito in carcere per la sua partecipazione al primo atto di esproprio, una rapina a un" agenzia di cambio che si è conclusa con la morte di un poliziotto, condannato a venticinque anni da passare a Ushuaia, il penitenziario da dove non si esce mai vivi, decide che Perez Millan la deve pagare. Simula la pazzia, del resto lui è un medico e un biologo e gli riesce facile farsi passare per matto. Fa in questo modo perché tutti sanno che i pazzi di Ushuaia vengono rinchiusi nell'"Ospicio" di calle Vieytes. Quando arriva al manicomio viene però sistemato in un padiglione diverso da quello in cui sta Perez Millan. Ma non si perde d'animo.
Un gruppo di anarchici di Avellaneda, coi quali è riuscito a mettersi in contatto, gli fa avere una rivoltella e Boris, così si chiama, convince Esteban Lucich a fare giustizia.
Lucich, un operaio istriano lì rinchiuso iscritto alla FORA, ha libero accesso in tutti i reparti. E' infatti un "loquito bueno", un matterello innocuo insomma, che pulisce le scarpe e fa delle commissioni in cambio di qualche spicciolo. Riesce così facilmente ad arrivare alla camera di Perez, spiana la pistola e gli dice: "Questo te lo manda Wilckens", e il 9.11.1925 gli pianta una pallottola in un polmone. Mentre Millan cerca di fuggire gli spara ancora nella schiena. Dopo poche ore di agonia l'ufficiale muore.
Lucich gli sopravviverà per quasi trent'anni, morirà infatti nel 1955 senza mai essere uscito dal manicomio.
Wladimirovich invece muore poco dopo. Subito i dirigenti del carcere capiscono che dietro l'assassinio dell'ufficiale c'è quell'uomo dall'aspetto mite e gentile, che è nato in seno a una famiglia appartenente alla nobiltà russa. Lo riportano così a Ushuaia. Qui i secondini a furia di botte gli spezzano la spina dorsale e Boris passerà i suoi ultimi mesi di vita a strisciare per terra continuando a parlare con i suoi compagni di prigionia delle virtù del vegetarianismo e della società che abolirà il privilegio e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
Ad eccezione dei giornali anarchici, che pubblicarono testimonianze e lunghi e circostanziati articoli, scenderà subito una coltre di silenzio su tutto quello che era successo in quelle sterminate pianure, e tutto fu subito dimenticato.
I morti tra i soldati furono sei, gli scioperanti ammazzati più di 1500. La chiesa non posò sulle loro tombe nemmeno una croce.
Oggi nella pampa, qua e là, perse nell'erba o presso i muri polverosi delle estancias, ci sono resti di croci di ferro o di marmo. Tutto quello che rimane di quelle memorie.
Osvaldo Bayer, storico, investigatore sociale e anarchico, ha scritto un libro diviso in quattro volumi su quegli avvenimenti, libro che ha intitolato "La Patagonia Rebelde". I suoi libri sugli anarchici argentini, sulle loro lotte e i loro sogni, sono stati bruciati con furore parossistico dai generali argentini. Quegli stessi che, in nome della difesa dei valori cristiani e nazionali, hanno torturato, stuprato e infine ucciso la parte migliore della gioventù argentina. David Vinas ha pubblicato un romanzo: "Los duenos de la tierra" su quelle lotte, e Francisco Colaone in "Come murio el Chilote Otoy" ricorda come alcuni sopravvissuti riuscirono a passare la frontiera con il Cile.
Nel 1974 uscì un film dal titolo "Patagonia Rebelde" di Hector Olivera a cui Osvaldo Bayer ha fatto da consulente. Lo stesso anno il film vinse il primo premio al festival cinematografico di Berlino. Questo film, malgrado abbia vinto un premio tanto prestigioso, non è mai stato proiettato in Italia.
[Altre informazioni: http://libcom.org - http://it.peacereporter.net - http://ita.anarchopedia.org - www.revolutionbythebook.akpress.org]