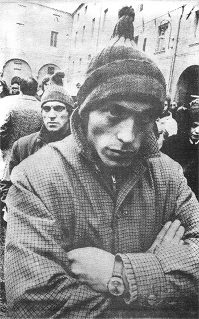Nella CGIL esistono oggi tre correnti principali, corrispondenti ai militanti, iscritti ai sindacati, di tre partiti: PCI, PSU, PSIUP. All'interno di queste tre correnti esistono posizioni sovente assai differenziate sui vari temi di politica sindacale; nondimeno è sulla base di accordi fra le tre correnti che si determina la linea politica e l'attività dei vari sindacati e della Confederazione. Meno che mai oggi questo tipo di correnti nel sindacato è atto a garantire la circolazione di idee e un processo genuinamente democratico di formazione delle decisioni e della linea. Il voto di astensione dei dirigenti comunisti e socialdemocratici della CGIL al Parlamento, sul piano Pieraccini, concordato tra i vertici supremi delle correnti di partito del PCI e del PSU, senza discussione nell'organizzazione, è solo un esempio; altri se ne potrebbero fare.9 La corrente comunista, quella di gran lunga più grande e dotata di quadri, registra oramai da tempo nella sua base i più vivaci fermenti critici verso la politica dei vertici della Confederazione, e vi si stanno formando posizioni politiche differenti. Per questo i burocrati che la inquadrano e dirigono hanno ridotto al minimo o a nulla le riunioni e le discussioni al suo interno. All'ultimo Congresso confederale essa non è mai stata riunita; le decisioni circa il suo comportamento vennero prese dai suoi maggiori dirigenti.
Tutto ciò tende a dare il quadro delle carenze profonde in materia di democrazia interna nella CGIL. Della struttura burocratica della Confederazione componente essenziale è il tipo di correnti, formate in base ad una tessera di partito e non a posizioni omogenee dei militanti del sindacato sulle varie questioni di cui quest'ultimo si occupa. Sicché, col pretesto della disciplina di partito, i vertici delle correnti (che sono parte integrante di più vasti vertici di partito) impongono una linea concordata al loro livello alla base sindacale. Premessa indispensabile ad un democratico sviluppo della vita e dell'attività della CGIL è quindi la liquidazione delle correnti di partito. Non è un caso che quanti oggi, ai vertici del movimento operaio, si sciacquano la bocca con la "autonomia" del sindacato e con discorsi sulla necessità di superare le correnti di partito, non abbiano mosso sinora un solo passo concreto in questa direzione, con l'eccezione parziale della tentennante corrente del PSIUP, sempre più costretta in minoranza nella Confederazione di fronte al consolidarsi del blocco PCI-PSU.
Ecco ora anche uno schizzo della collocazione nella CGIL delle correnti del PSU e del PSIUP.
Uno dei fattori fondamentali tra quanti spingono ad una unificazione sindacale che sposti a destra rispetto all'equilibrio attuale la nuova formazione unitaria che eventualmente si formerà, è dato dalla corrente socialdemocratica in seno alla CGIL, il cui ruolo pratico si è sempre meglio venuto caratterizzando negli ultimi tempi in un duplice senso: 1) agitare periodicamente e mai comunque sotterrare del tutto la minaccia di una scissione; attraverso ciò, strappare continue concessioni di ogni tipo; 2) giocare permanentemente un ruolo pompiere nelle più disparate vicende sindacali, ritardando le prese di posizione del sindacato quando vanno prese urgentemente, premendo per annacquare continuamente le piattaforme rivendicative, cercando di dilazionare e spezzettare le varie lotte ecc. Questo gioco in generale riesce. Il disegno generale consiste nell'utilizzo di ambo le strade accennate per stimolare il processo di integrazione della CGIL in una logica subalterna alle scelte generali del sistema capitalistico e dello Stato.
Il PSU è forte nel movimento sindacale. Ha un suo sindacato giallo, la UIL; dispone della seconda corrente, come forza d'apparato, nella CGIL. A questa forza non corrispondono affatto la presa e l'influenza socialdemocratiche in seno ai lavoratori. La UIL e la corrente socialdemocratica nella CGIL dispongono di pochi quadri e attivisti, di un'influenza tutt'al più generica su strati certo non trascurabili, ma neppure paragonabili a quelli sotto influenza comunista o cattolica nella classe operaia italiana. La UIL è sovente associata alle più squallide operazioni aziendali di piccolo cabotaggio ruffiano, ed in ciò ha "quadri."
La forza del PSU deriva essenzialmente dalla sua collocazione d'apparato, che gli è in ultima analisi garantita dalla politica del PCI, il quale ha una concezione dell'unità del movimento operaio che lo porta a continue concessioni d'ogni tipo a destra. Tale tipo di concezione unitaria è in armonia con la linea generale del Partito comunista italiano, riformista, che ha smarrito ogni concezione classista dello Stato e dei rapporti di produzione, che non intende più lo sfruttamento capitalistico come qualcosa di organicamente connaturato a strutture e rapporti da rovesciare insieme a tutto l'apparato di potere borghese. Le concezioni opportunistiche del PSU e del PCI, laddove anche formalmente coincidono, sono penetrate all'interno della CGIL e fanno ormai parte del suo discorso strategico d'assieme, mascherate in modo maldestro dal tentativo di farle passare come "discorsi nuovi" frutto di un'autonoma e "non-ideologica" (!) elaborazione.
Chiunque abbia un minimo di esperienza dell'azione sindacale sa quanto sia importante il ruolo degli apparati in ogni momento della stessa (elaborazione degli obiettivi, forme di lotta, allargamento o meno di quest'ultima, trattative ecc.); quindi quanto necessaria spesso sia la tempestività dell'intervento, e importante la forma del medesimo; quindi quanto, pur sbandierando le più belle volontà unitarie e di lotta, sia possibile in concreto frenare e sabotare le lotte... E' questo il prezzo reale che il PCI paga al PSU, cedendo alle pressioni e ai ricatti di questo.
La corrente del PSIUP richiede un discorso diverso: continuamente discriminata nella suddivisione degli incarichi dirigenti dalle due correnti principali, è spinta da questo e dalle ragioni che hanno condotto gli attuali socialisti unitari a costituirsi in partito a precisare una sua linea di opposizione al processo involutivo che investe la CGIL e tutto il movimento operaio in generale. Non ne va però sopravvalutato il peso nella base della Confederazione, ridotto in quanto i quadri combattivi di cui dispone non sono molti e sovrabbondano elementi opportunisti tra i suoi funzionari sindacali; potrà giocare un certo ruolo, accanto a forze più ampie, di provenienza comunista, che rifiutano la politica dei vertici della CGIL e che vengono attualmente precisando le loro posizioni critiche verso tale politica. In tal senso appaiono positive le intenzioni di Foa di agire perché nella Confederazione vengano seppellite per sempre le intenzioni di firmare un accordo quadro, com'è stato importante il suo voto contrario, in Parlamento, al piano capitalistico, per quanto motivato con taluni argomenti deboli ed equivoci (il che non stimola l'appoggio, alla sua azione, di una parte almeno della base della CGIL), accanto ad altri più validi.
Si comprende quindi come l'involuzione della politica della CGIL sia parte di un più ampio e organico processo di socialdemocratizzazione, al quale per ora si oppongono forze esigue e per altro divise. Gli autori di questa "lettera aperta," che si collocano come parte di tale nascente "opposizione di sinistra," intendono ribadire la propria convinzione che dallo sviluppo delle contraddizioni di classe potrà sorgere e forgiarsi una nuova formazione politica rivoluzionaria di massa, ad una condizione precisa e ineluttabile: che le avanguardie coscienti attuali operino attivamente per quest'obiettivo di fondo. Alla dimensione sindacale di quest'operare è dedicata l'ultima parte della "lettera aperta."
Gli autori di essa intendono inoltre manifestare la propria risoluta opposizione al tentativo messo in atto dai riformisti, oggi come ieri, in Italia come altrove, da parte dei quali, abbacinati dagli aspetti formali della democrazia borghese, la lotta del movimento operaio viene scissa e ridotta in due momenti limitati: quello dell'azione economico-rivendicativa (di pertinenza dei sindacati) e quello dell'azione politico-parlamentare (di pertinenza dei partiti)10. Gli autori di questa "lettera aperta" concepiscono la lotta di classe come lotta che investe tutti i momenti dell'attività sociale e richiede nuovi rapporti di potere: la lotta di classe è lotta politica per il potere proprio in quanto è complessiva. La lotta politica della classe operaia quindi necessita di sue dimensioni rivendicative e salariali, come di svilupparsi negli enti locali e nel Parlamento; ma necessita anche, e soprattutto, di azioni di massa per obiettivi politici di natura transitoria (per esempio: nazionalizzazione con controllo operaio), per la lotta contro l'imperialismo e i patti militari (per esempio: per l'uscita immediata dell'Italia dalla NATO); necessita di sviluppare la propaganda di solidarietà e l'aiuto pratico ai vari comparti della rivoluzione mondiale; come necessita di un'attività costante di elaborazione e di educazione ideologica e teorica dei militanti, ecc. È impossibile non vedere tutti questi momenti dell'attività del movimento operaio, e gli strumenti per le diverse attività, come strettamente uniti tra loro, e vederli invece scissi. Solo una visione unitaria dei vari problemi e delle lotte permette alla lotta di classe e di svilupparsi, sino a porre all'ordine del giorno il rovesciamento dei rapporti di potere e la distruzione dello Stato borghese, come compiti pratici immediati della lotta stessa. Nella lotta di classe per il socialismo l'azione economica e rivendicativa quindi costituisce un momento particolare della lotta politica, subordinato ad essa.[11]
Però, per quanto la lotta economica costituisca una dimensione particolare e limitata dell'attività del proletariato, cui spesso essa si riduce in lunghi periodi di tregua relativa nei rapporti di classe, questo, classe economicamente sfruttata, non può rinunciarvi senza retrocedere in tutti i campi e sul piano dei rapporti di forza con la borghesia.
Nel senso di quanto esposto si individua nel partito rivoluzionario lo strumento essenziale della lotta politica del proletariato. Ciò non significa affatto direzione del sindacato da parte del partito: significa semplicemente coscienza del ruolo parziale della lotta sindacale, ed esigenza di una collaborazione tra partito operaio e sindacato di classe in ordine a quei problemi dei quali naturalmente si occupa il sindacato; l'intervento del partito è necessario in funzione di sbocchi più ampi e obiettivi più avanzati, trascrescenti la dimensione economico-rivendicativa. Ciò significa semplicemente come il ruolo di direzione di un processo di rivoluzione sociale (che non significa dirigere burocraticamente le organizzazioni di massa, ma egemonizzarle, influenzarle dall'interno e dall'esterno) spetti al partito e non al sindacato.
Al tempo stesso il sindacato di classe è scuola di auto-educazione delle masse, luogo di formazione di coscienze socialiste a livello elementare; per questo e in questo modo un militante marxista considera l'autonomia necessaria alle organizzazioni sindacali. Va detto di più: e cioè solo un sindacato classista, ossia ligio fino in fondo alle esigenze e alle rivendicazioni del proletariato, può essere un organismo autonomo, al cui interno esiste una vivace democrazia; non potrà essere tale un sindacato di continuo pesantemente condizionato dalle esigenze contingenti e di fondo del sistema, costretto a subirne la politica dei redditi e a ingabbiare e dirottare ogni movimento rivendicativo di una certa ampiezza. Il sindacato riformista, integrato, neo-capitalistico non può essere altro che profondamente burocratizzato e subordinato a decisioni politiche prese all'esterno o ai vertici senza considerazione degli interessi e della coscienza degli organizzati e dei lavoratori, se non in via del tutto subordinata.
L'accordo quadro, che il gruppo dirigente della CGIL vuol far suo come cornice dell'azione rivendicativa, non imprigionerà il sindacato in una dimensione economicistica in astratto. Questa è la collocazione normale e il limite naturale, in una situazione di democrazia borghese, delle organizzazioni sindacali, quale che ne sia la linea ideologica. L'accordo quadro significherà ancorare tutto il movimento sindacale italiano ad una linea economicistica estremamente arretrata, conseguenza e causa a sua volta dell'atomizzazione del proletariato, al di sotto delle più elementari esigenze e rivendicazioni dei lavoratori e tale da non permettere mobilitazioni di massa per obiettivi più ampi, che mettano sul tappeto la questione del potere proletario.
Note
[9] La Conferenza nazionale consultiva della CGIL, tenutasi ad Ariccia, tanto propagandata come esempio di consultazione democratica della base, è stata in realtà un'assemblea prevalentemente di funzionari, che nessun congresso o assemblea o istanza di base aveva eletto come delegati; grazie ai risultati dei lavori di quest'assemblea che nessuno ha eletto gli organismi dirigenti nazionali della CGIL avranno un alibi "democratico" per prendere decisioni importanti di rilancio di azioni rivendicative e della politica di unità sindacale, (che la base dei sindacati non ha discusso prima della Conferenza) secondo la linea verticistica e opportunistica che gli autori di questa "lettera aperta" criticano.
[10] Ecco perché il discorso di Ingrao non è solo di retroguardia, ma anche riformista, quando propone il falso problema dello svincolo da cariche partitiche e incarichi parlamentari da parte dei dirigenti sindacali, come problema centrale dell'autonomia dei sindacati dai partiti. È di Ingrao, come di tutto il gruppo dirigente del PCI, una visione non classista dello Stato italiano e dei suoi organi: di qui tutta una concezione errata ed estremamente pericolosa sulla politica e la collocazione del movimento sindacale in rapporto allo Stato stesso.
[11] Nel quadro esemplificativo qui fornito gli autori della "lettera aperta" si sono riferiti a situazioni di democrazia borghese, quali quelle dell'Europa occidentale.

Lettera aperta ai militanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e dei partiti operai
- 1. Premessa
- 2. Le posizioni della CISL sull'accordo quadro
- 3. Le posizioni della CGIL sull'accordo quadro
- 4. Esiste una divergenza politica tra la FIOM e la CGIL?
- 5. Quale tipo di unità sindacale si sta realizzando?
- 6. Correnti della CGIL e partiti del movimento operaio; rapporto partito-sindacato
- 7. La lotta per una diversa politica da parte della CGIL